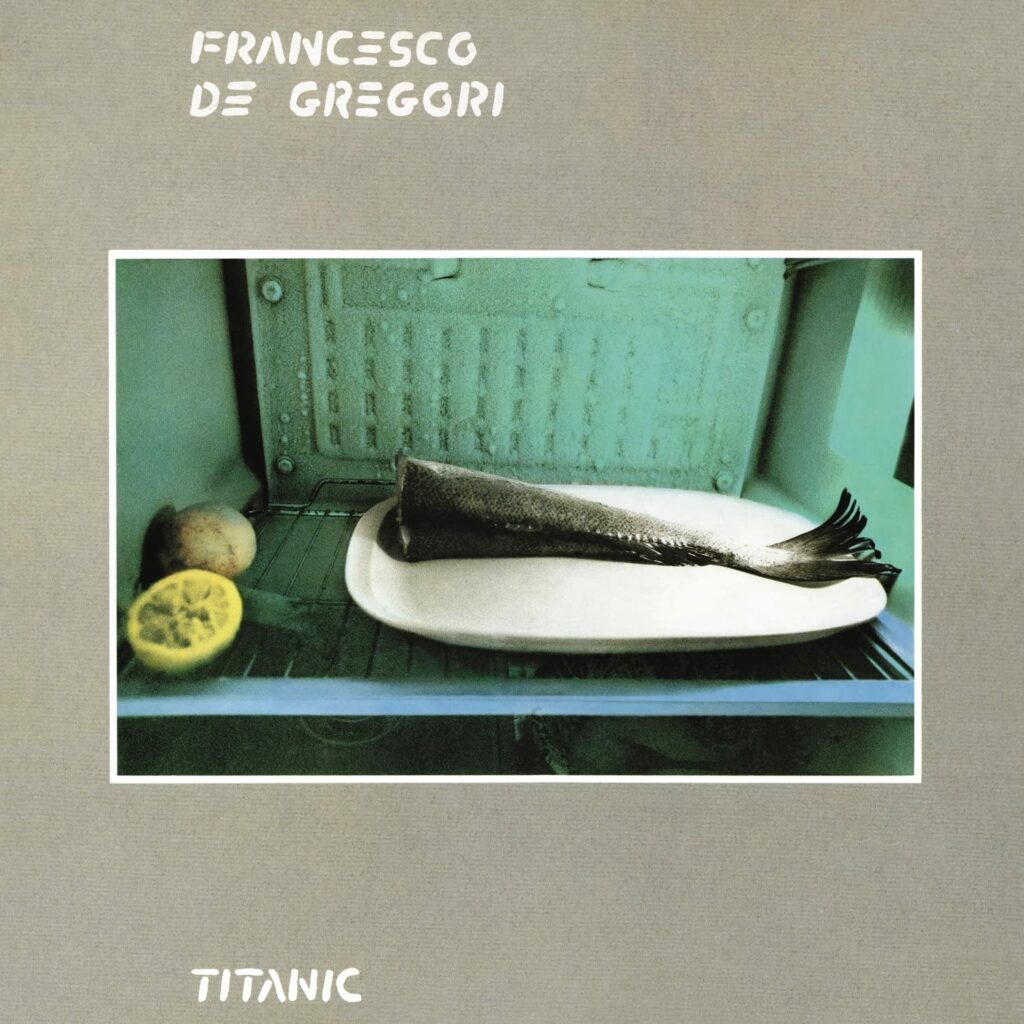Sogno americano
di Giancarlo Durante
Ma non scherziamo. Negli Stati Uniti bisogna andarci. E, per chi ne ha la possibilità, consiglio di andarci spesso. Escludere gli USA dagli itinerari turistici solo per partito preso, per una visione grossolanamente ideologica, perché gli States sono marchiati come regno del male, fa parte di un anti americanismo ormai fuori moda e fuori luogo, tribale, un falso apoftegma per gli amanti del greco antico, perché confonde le enormi responsabilità che gli USA hanno avute nelle politiche d’imperialismo a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale con le infinite sfaccettature di un mondo che contiene tutto e il suo contrario e la cui complessa storia sarebbe un delitto ignorare. Deponete, perciò, cari amici, l’abito del turista europeo(peggio italiano, peggio ancora di sinistra)spocchioso e con la puzza al naso. Allenate la vista l’olfatto l’udito e anche il gusto agli eccessi, lasciandovi trasportare dalla voracità del conoscere, dalla bulimia di nuove esperienze sensoriali e soprattutto abituatevi a standard abnormemente amplificati:createvi un nuovo concetto di dimensione. Perché in USA la quantità, per incanto, si trasforma in qualità. Dalle piazze ai giardini, dai grattacieli all’intensità delle luci, dai suoni alle pinte di birra, dalle prime colazioni dei cuochi obesi dei college alle adunate delle più pittoresche sette religiose, tutto in America è esagerato, dilatato. Bello perché profondamente diverso dalla nostra tranquilla ipocrita realtà strapaesana. Se non c’è questa precisa disposizione di animo, se non si materializza questa speciale“apertura”mentale, lasciate stare: gli States non sono fatti per voi! New York, poi, è una città stupenda. E per chi ama il cinema, come si fa a non associarla all’immagine che viene fuori dai films di Woody Allen, contaminati dalle atmosfere patinate e dai riti e vizi della medio-alta borghesia newyorkese, che ignora l’infimo dei sobborghi violenti e delle sterminate e dimenticate periferie della città? New York rimane, comunque, impareggiabile:un luogo dove ti può capitare di essere proiettato in un futuro astratto, apparentemente anonimo, ipertrofico e ipertecnologico, come il World Trade Center, con l’ascensore che in 1 minuto ti proietta al 100° piano o a sperimentare l’inno apotropaico della scultura del Bowling Green Bull a Wall Street. Una città dove puoi aspettarti di essere “sequestrato” dalla simpatica proprietaria di un bar (strano i chioschi a New York non possono servire alcolici! ), alla quale non sembra vero di poter raccontare di essersi recata due volte in Italia a degli italiani:giusto per farti illudere un attimo di essere una persona importante.

E insieme restare basito di fronte alla scena del gruppetto di ragazzine sorvegliate da un anziano “signore” mentre escono da un Mac Donald’s per fuggire di corsa chissà dove nell’indifferenza della moltitudine della Quinta Strada. Come restare impassibili , poi, ai canti e balli lungo la spiaggia di Long Beach o al frastuono del Luna Park di Coney Island o quando vai a cercare ciò che resta dei fasti di quella che, una volta, era la Little Italy, ingoiata dagli impenetrabili quartieri di China-Town?E se per avventura ti dovesse capitare di visitare qualcuno degli stupendi Colleges Universitari del New England, non sarebbe difficile calpestare immensi spazi verdi, boschi abitati dagli animaletti più strani che pensavi comparissero solo nelle storie di Walt Disney. In quale altro luogo al mondo puoi, poi, scoprire lo stesso orgoglio e lo stesso patriottismo che mostrano gli americani nella cerimonia dell’alzabandiera, se non recandoti a Philadelphia, al Memorial Day? Come pure qualcosa in più potrai capire della recente storia americana se ti avventuri sul lungomare di Baltimora, luogo citato, persino, nei fumetti del Grande Blek. E quando ti rechi a Boston, sai che ti trovi in uno dei maggiori templi della cultura, della storia e del progresso non solo americano, sede dell’ Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. E nessuna emozione ti assale nell’aggirarti a pochi passi dalla Casa Bianca o, autorizzato, quando ti permettono di visitare un’ala del Campidoglio? E non dirmi che non ti solletica un po’ entrare in una capsula spaziale al National Air and Space Museum di Washington? Con qualche giorno in più di permanenza potresti, poi, solcare in canoa gli incontaminati corsi d’acqua e i laghi dell’Oregon, lo Stato americano che offre uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo. E andare a vedere le famose Cascate, e gli Stati del Middle-West e quelli del Sud, i deserti dell’Arizona e il New Mexico, la Florida, la California, la musica di New Orleans, la Silicon Valley e Disneyland, e così via. La Repubblica Federale degli Stati Uniti d’America conta 50 Stati, pochi localizzati fuori dal territorio americano, gli altri distribuiti su di una superficie che è più di trenta volte quella dell’Italia. All’interno di ciascuno di questi stati trovi una ricca, caleidoscopica società pulsante, lontana, però, dagli stilemi e dai ritmi di vita di noi, abitanti del Vecchio Continente. Non è una novità, quindi, se scopri che in America c’è troppo da conoscere e troppo da vedere e appare naturale mostrare un iniziale moto di rigetto. Iniziale, però. Perché se ti riprendi, in America poi ci torni. Così alla fine ti accorgi che le cose sono tante, troppe, da poter essere contenute e banalizzate in una paginetta del blog di Carlo. Sterminati i territori e le metropoli e sterminata la letteratura americana. Così, col rischio di avvicinarmi pericolosamente al senso del ridicolo oso proporvi due testi che mi vengono in mente (il tempo sta diventando sempre più risicato e da leggere c’è ancora tanto e pure i luoghi da visitare al mondo sono ancora troppi e diversi sono gli spezzoni di vita vera ancora da vivere). Il primo un po’ fuori dagli schemi abituali é formato da storie di ordinaria normalità, un autentico gioiello di lettura “leggera”che esce fuori da un libro edito nel lontano 1964 e acquistato per 350 lire come Oscar Mondadori, che si chiama ”Che ve ne sembra dell’America?” e l’autore non è di quelli stra-conosciuti:William Saroyan. Il secondo è dell’arci-noto David Foster Wallace. E mi sembra illuminante riportarvi qualche passo significativo, tratto da uno dei suoi pamphlets più noti“Considera l’Aragosta”.

Il Festival dell’Aragosta del Maine, immenso , pungente ed estremamente ben pubblicizzato, si tiene ogni anno a fine luglio. . . L’affluenza totale quest’anno ha superato le centomila persone, . . Food & Wine proclamava il F. A. M. forse la migliore festa a tema gastronomico del mondo. Ricordo che l’industria alimentare statunitense produce circa quaranta milioni di chili di aragosta e il Maine è responsabile per più della metà del totale. Punti salienti di questa edizione sono: concerti di Lee Ann Womack e degli Orleans, concorso di bellezza, annuale Dea Marina del Maine, grande Parata del Sabato, corsa sulle casse in memoria di William Atwood, di domenica:gara di cucina amatoriale , giostre e attrazioni da luna park, e stand di roba da mangiare , oltre al al tendone del Ristorante del F. A. M. , dove vengono consumati qualcosa come più di undicimila chili di aragosta del Maine appena pescata, cotti nella Pentola per aragosta più grande del mondo vicino all’ingresso nord della Fiera. . . Il Festival , alla fine, non é poi così diverso dalle sagre del granchio nella regione del di Tidewater, dalle sagre del granturco del Midwest, o del chili con carne in Texas, eccetera, e con queste ha in comune il paradosso di fondo di tutti gli eventi commerciali demotici e brulicanti: non è per tutti. In realtà c’è molto da dire sulle differenze fra la Rockland operaia e il sapore populista del festival vs l’agiata ed elitaria Camden con il suo panorama costoso e i negozi ceduti a maglioni costosissimi e schiere di villette trasformate in B&B. . . . Essere turisti americani di massa per me significa diventare puri americani dell’ultimo tipo ; alieni, ignoranti, smaniosi di qualsiasi cosa che non si potrà mai avere, delusi come non si potrà mai ammettere di essere. Significa contaminare, per mera ontologia, quell’ incontaminatezza che si è andati a sperimentare. Significa imporre la propria presenza in luoghi che sarebbero, in tutti i sensi non-economici, migliori e più veri senza la nostra debordante presenza. Scrivendo queste righe mi è venuto alla mente quel che un po’ di anni fa mi confessò una cara amica venuta a trovarmi per la prima volta a Cava. Ti devo dire la verità, mi disse, seria e con un tono solenne, asseverativo, ho preso un maglione in un negozio di Cava; ma l’educazione e la bonomia che ho trovato comprando un vaso di ceramica a Vietri non le ho riscontrate nella vostra città. Sarebbe lungo raccontarti, le risposi, cara mia, ma la gente di Vietri, sai, ha origini etniche un po’ diverse da quelle dei cavesi. Poi l’aria di mare. . . ! Tanto per dire:fantasioso e originale archiviare con una battuta”turistica” Cava e i suoi cittadini, un po’ più arduo farlo quando si maneggiano America e Americani!